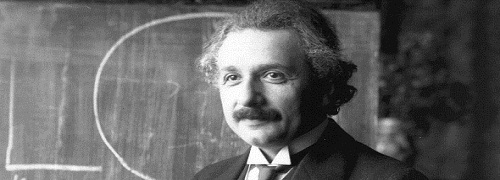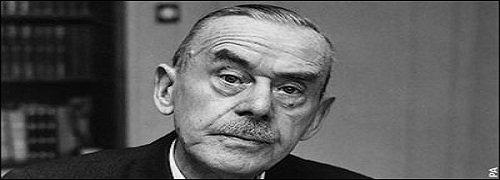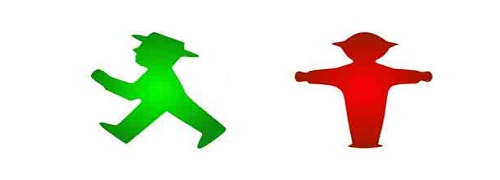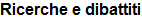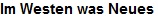„Il Führer è stato ancora una volta troppo umano“
Cosa determinò l’eccezionale coesione della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale? Quali caratteristiche strutturali e psicologiche assenti in altri eserciti motivarono i soldati tedeschi a combattere fino alla fine una guerra ormai perduta? A queste domande cercò già durante la guerra di rispondere la Psychological Warfare Division del Comando Supremo Alleato. Da queste indagini nacquero un’interpretazione storiografica e una teoria di sociologia militare che vengono ancora oggi dibattute dalla comunità scientifica. La tesi, avanzata da due membri della Divisione, Edward Shils e Morris Janowitz, in un saggio pubblicato nel 1948, riconduceva la coesione dell’esercito tedesco al fatto che esso valorizzava il gruppo primario. Non tanto l’ideologia quanto una struttura che metteva in primo piano i legami interpersonali aveva cementato la Wehrmacht in modo così saldo e duraturo[1]. Ancora oggi questi temi sono al centro di ricerche storiografiche[2], soprattutto da quando la mostra sui crimini della Wehrmacht, organizzata dall’Institut für Sozialforschung di Amburgo nel1995, ha portato violentemente all’attenzione della storiografia il ruolo dell’esercito nei crimini del regime.
Nel 2001 lo storico tedesco S. Neitzel ha rinvenuto nei National Archives di Londra e di Washington una fonte fino ad allora poco nota che consente di rispondere a queste e simili domande in modo eccezionalmente approfondito. Si tratta di ca. 150000 pagine di protocolli che riportano le intercettazioni di colloqui tra soldati, tedeschi e italiani, prigionieri degli Alleati. Le intercettazioni insieme agli interrogatori servirono allora alla human intelligence per acquisire informazioni sugli eserciti nemici. Oggi costituiscono una preziosa fonte d’informazione sulla mentalità, la percezione della guerra e l’esperienza dei soldati. Una fonte che consente di osservare l’esperienza di guerra molto da vicino e senza i filtri posti da elementi “intenzionali“ di costruzione di una determinata immagine o memoria. Fino ad oggi, infatti, l’esperienza di guerra durante il secondo conflitto mondiale – un tema che ha ricevuto grossa attenzione dalla storiografia internazionale degli ultimi vent’anni – è stata studiata principalmente attraverso memorie o interviste, una risorsa preziosa ma che presenta notevoli pericoli di distorsione. Per ovviare agli inconvenienti di questa fonte una stagione di studi ha valorizzato la posta militare[3], considerata più “vicina“ all’esperienza del fronte. Anche questa seconda fonte però, sebbene rispetto alle memorie sia meno “inquinata“ dall’esperienza successiva e dalla costruzione intenzionale di un’immagine, non offre un accesso così diretto. Ciò perché anche nelle lettere dal fronte i soldati volevano trasmettere ai destinatari un’interpretazione della loro esperienza per placare le ansie dei propri congiunti o per creare nella scrittura un’immagine idealizzata di sé e delle proprie azioni al fronte. I protocolli rinvenuti da Neitzel sono invece una fonte molto diretta: nei loro colloqui intercettati segretamente i soldati parlavano in modo abbastanza libero della loro esperienza, del senso della guerra, dell’uccidere e del loro rapporto con le ideologie e i regimi che li avevano mandati a fronte. Neitzel ha pubblicato dopo pochi anni alcuni estratti di protocolli che riportano conversazioni tra generali tedeschi[4]. Nel frattempo ha costituito un gruppo di ricerca insieme a H. Welzer[5], professore di Psicologia Sociale a Essen, che include– principalmente giovani ricercatori tedeschi. I risultati del lavoro sono a disposizione del pubblico in questo volume collettaneo, che compara le esperienze degli eserciti dell’Asse, ed in un volume che parallelamente hanno scritto Neitzel e Welzer sui soldati tedeschi[6]. In più il volume comprende alcuni saggi basati su fonti diverse: un saggio di Matthias Uhl sugli interrogatori di generali tedeschi realizzati dai servizi segreti sovietici, conservati oggi negli archivi di Mosca; un saggio di Takuma Melber sugli interrogatori di soldati giapponesi; due saggi di Felix Römer e Falko Bell sulla human intelligence britannica e americana.
Il libro – spiega il primo saggio metodologico di Christian Gudehus – mira a descrivere la mentalità dei soldati, che gli autori definiscono “cornice referenziale” (Referenzrahmen). Ciò che interessa loro dunque è la struttura più che l’individuo, la cornice mentale che rendeva l’esperienza di guerra possibile in quanto strutturabile e linguisticamente comunicabile. Nello stesso tempo la struttura non è concepita come una un dato preesistente ma come qualcosa che si realizza solo nell’azione sociale. I concetti di habitus, proposto da P. Bourdieau, e di configurazione, usato invece da N. Elias, sono molto vicini agli strumenti metodologici usati dagli autori. Rispetto a questi però gli autori mettono maggiormente l’accento sul tema della Aneignung (appropriazione), un concetto chiave della storia del quotidiano proposto da A. Ludtke[7]. Con Aneignung si indica la modalità concreta con cui l’attore sociale si “appropria” delle strutture sociali nel metterle in atto. Ciò vuol dire che l’individuo stabilisce con le strutture un rapporto creativo e non solo di mera esecuzione. Per realizzare queste indicazioni metodologiche i ricercatori del gruppo hanno cercato di far parlare la fonte nel modo più diretto possibile, ponendo solo alcune limitazioni generali alla loro voce immediata: una separazione dell’esperienza in diverse “cornici referenziali” e la contestualizzazione del contenuto dei colloqui nel quadro storico complessivo, che lo storico conosce in modo ovviamente più ampio e diversamente strutturato rispetto ai soldati.
Il metodo di lavoro dei ricercatori del gruppo è stato definito in modo abbastanza rigido per garantire una procedura uniforme e il più possibile scientifica. Ai protocolli è stato applicato il metodo della “codificazione” del testo. I ricercatori hanno letto i testi e hanno classificato ogni passaggio con un certo codice. Questi codici però non sono stati stabiliti prima della lettura ma elaborati in una lettura precedente dei testi stessi. In questo primo stadio i ricercatori hanno analizzato i protocolli e a partire da questi hanno elaborato i codici. Dal confronto dei risultati dei diversi ricercatori è stato costituito un “albero di codici” unico – contenente 750 codici divisi in categorie, ad es. “altri”, “guerra”, “esercito”, “sul parlante”, “altri aspetti”- che poi è stato applicato nella ricerca successiva. Con questo metodo è stata garantita la maggior aderenza possibile al testo che riporta le categorie interpretative e i giudizi degli attori sociali stessi. Ciò garantisce che la “teoria venga costruita sul materiale, pur includendo dei presupposti e soprattutto una conoscenza preliminare” (p. 46).
I quindici saggi che compongono il testo sono divisi in quattro parti: teoria e metodo, fonti e strutture, Wehrmacht e SS intercettati, alleati intercettati. Oltre al saggio metodologico di Gudehus appena descritto vi è nella prima sezione un testo su “Comunità popolare nella Wehrmacht? Milieu, mentalità e morale militare nelle forze armate dello stato nazionalsocialista” scritto dal giovane storico F. Römer. L’autore ha recentemente pubblicato la sua dissertazione su origine, ricezione ed esecuzione del cosiddetto Kommissarbefehl (“ordine dei commissari”), cioè le Indicazioni sul trattamento dei commissari politici dell’Armata rossa emanate da Hitler nel giugno del 1941[8]. Römer usa i protocolli per rispondere alla questione se la Wehrmacht sia riuscita o meno a eliminare gli steccati sociali e religiosi omogeneizzando l’esperienza e la percezione di sé dei suoi membri. In altre parole l’autore si chiede se la Wehrmacht abbia realizzato al suo interno la Volksgemeinschaft, il progetto sociale nazionalsocialista di trasformazione della società tedesca in una comunità popolare di eguali. Römer analizza prima di tutto le opinioni dei soldati riguardo al nazionalsocialismo e nota che confessione e appartenenza di classe non avevano su di esse un’influenza decisiva. Vi era tra i soldati di estrazione operaia però un numero maggiore di soggetti che si dichiaravano antinazisti. Ciò dimostra che l’appartenenza di classe, nonostante avesse perso ampiamente di valore, rappresentava per gli operai ancora in una certa misura ancora una “formula identitaria“. Römer inoltre analizza come i soldati percepivano la Wehrmacht stessa e qui rileva una quasi completa unanimità di giudizi positivi sull’esercito, anche da parte di chi era contro il regime. Vi era, dunque, un’adesione per certi versi impolitica all’istituzione militare che continuava a rappresentare per molti l’incarnazione della nazione, come cosa distinta dal nazismo. Nello stesso senso un saggio di Alexander Hoerkens rileva come nelle discussioni tra soldati le opinioni divergessero solo su temi come il giudizio su Hitler, il razzismo e l’antisemitismo. Quando si discuteva della Wehrmacht invece vi era una notevole convergenza di opinioni. La stessa condivisa accettazione dell’istituzione militare è rilevata nei discorsi di soldati austriaci analizzati da Richard Germann. La Wehrmacht, dunque, funzionava come una sorta di melting pot che eliminava decisamente anche le differenze regionali. Questa cultura unitaria differenziala Wehrmacht fortemente dalle SS, le cui intercettazioni sono analizzate da Katharina Straub.
Tra i valori nazionali di cui l’esercito era considerato espressione spicca, nell’analisi Römer, il topos dell’efficienza. Questo elemento di identificazione con la guerra è stato rilevato anche da A. Lüdkte in un saggio di alcuni anni fa[9] ed ha a che fare con ciò che in Germania è spesso definito deutsche Qualitätsarbeit, il “lavoro tedesco di qualità” che secondo molti è una costante dell’identità nazionale tedesca. Dunque, conclude Römer, la base della coesione della Wehrmacht era soprattutto una perfetta coincidenza tra adesione primaria, cioè quella personale, e adesione secondaria, ovvero quella all’istituzione come portatrice di valori positivi. Per mostrare ai propri compagni di essere un buon camerata, insomma, bisognava mostrare il più possibile di aver assorbito i valori della struttura militare e di rispettarne le ingiunzioni[10].
Un saggio di Michaela Christ, autrice di interessanti studi su violenza, shoah e nazionalsocialismo[11], analizza il modo in cui i soldati parlavano della violenza. Una caratteristica ricorrente, secondo l’autrice, era il parlare della violenza in modo da discolpare se stessi, attribuendone le responsabilità ad altre istituzioni (in genere le SS e la Gestapo) o a un “noi” collettivo indefinito. Diffuso era anche il timore, del tutto immaginario, della “rappresaglia” da parte delle vittime che si sarebbero vendicate della violenza subita. Questa percezione della vittima come pericolosa proiettava sull’altro l’immagine di sé e serviva in primo luogo ad allontanare da sé la colpa, in secondo luogo a risolvere la dissonanza cognitiva tra l’esperienza della violenza perpetrata e il mantenimento di un sistema di valori in cui tale violenza era condannata.
Amedeo Osti Guerrazzi indaga, sulla base di intercettazioni di generali italiani durante la prigionia[12], come questi percepivano il regime e la sua crisi nel 1943. Secondo l’autore il ricordo del primo dopoguerra era un motivo importante della loro adesione al fascismo e rimaneva vivo nella memoria dei generali. Invece di esser percepito come vincitore della guerra combattuta per la nazione l’esercito, secondo i generali, era stato attaccato e disprezzato dalla società e non difeso dalla classe politica liberale. I generali erano molto critici verso gli errori compiuti dal regime negli ultimi anni, soprattutto verso quelli che avevano condotto alla catastrofe bellica, e guardavano con ansia al dopoguerra perché temevano una presa del potere da parte dei comunisti. Infine nei discorsi dei generali è possibile rinvenire la definizione del mito auto-assolutorio del bravo italiano che implica– la mancanza di una riflessione critica sul proprio passato.
Un secondo saggio sull’Italia di Daniela Wellnitz si chiede quanto i militari del Regio Esercito fossero fedeli al re e quanto al fascismo. La figura del re nei discorsi dei generali, rileva l’autrice, conserva un’aura intatta, nonostante si diffondessero alcuni dubbi e critiche su di lui dopo la fuga da Roma. Il re però rimase sempre una figura positiva, e ciò non solo sul piano politico ma anche emotivo. Vi era invece una forte critica al fascismo, che si riteneva avesse portato alla catastrofe bellica, e soprattutto a Mussolini che nei colloqui dei generali era quasi sinonimo di fascismo. Nel luglio-settembre 1943 Mussolini appariva ormai come un condottiero fallito, e quindi era visto con decisa ostilità dai militari. La scarsa motivazione dei soldati italiani durante la guerra viene ricondotta all’influsso demoralizzante dell’incompetenza militare della dirigenza fascista. Al contrario di quanto accadde nella Wehrmacht, dunque, la deludente esperienza del fronte costituì uno dei maggiori fattori di disgregazione dell’esercito italiano. Mentre l’efficienza della Wehrmacht rimase un forte tessuto connettivo anche quando la fase delle vittorie tedesche era terminata ormai da tempo, per gli italiani prevalevano delusione e incomprensione verso il regime.
Dei saggi che compongono il volume va infine menzionato quello di Anette Neder che studia la percezione dei soldati tedeschi prigionieri nei campi del Mediterraneo (Italia e Nord-Africa). Il saggio analizza in modo comparato quale percezione avessero i tedeschi delle altre nazioni in guerra. Il 95% dei numerosi giudizi sull’alleato italiano è negativo già prima del crollo dell’8 settembre. Il topos più diffuso sull‘italiano era la sua “naturale viltà sul campo di battaglia“ (p. 198) e l’“inadeguatezza alla vita da soldato”. Nelle esternazioni sugli italiani non ricorrono quasi mai teorie razziste, quanto piuttosto un insieme di pregiudizi formatisi in tempi lunghi (il prevalere dell’emotività sulla ragione come movente delle azioni, il disordine, la mancanza di disciplina e l’oziosità) accompagnati spesso da un richiamo al cambio di alleanza italiano nella prima guerra mondiale. L’immagine dei britannici era invece quasi sempre positiva. Anche qui però non si tratta tanto di stereotipi razziali quanto di esperienze fatte al fronte filtrate attraverso un bagaglio di stereotipi di lunga durata e poco legati all’ideologia nazionalsocialista. Nella percezione dei soldati dell’Unione Sovietica si trovano invece in egual numero immagini positive e negative. In questo caso, inoltre, l’autrice ritrova nelle affermazioni moltissimi stereotipi diffusi dalla propaganda. Ciò viene spiegato con il fatto che i soldati dei campi di prigionia mediterranei furono catturati prima dei loro commilitoni che combattevano su altri fronti e così, lontani dalla realtà della guerra, mantennero più a lungo le percezioni diffuse dall’indottrinamento del regime. La tesi dell’autrice è, dunque, che complessivamente l’immaginario dei soldati fosse determinato più da elementi “situativi“ che da elementi “intenzionali“, cioè legati all’ideologia nazionalsocialista.
L’interpretazione esplicitata da Neder è, in effetti, un filo rosso che attraversa tutto il libro. Complessivamente, si può dire, i saggi del libro tendono a supportare la tesi di coloro che danno poco peso all’ideologia nel determinare il comportamento dei soldati. L’esperienza di guerra sembra essere stata determinata più dalla concreta realtà del fronte che dall’indottrinamento ideologico. Inoltre risulterebbe decisivo il peso della socializzazione ai valori dell’esercito che manteneva una cultura per molti versi distinta rispetto a quella del regime. I due saggi sull’Italia mostrano come la fonte rinvenuta dagli storici tedeschi sia di portata limitata per uno studio comparato degli eserciti dell’Asse. Come ammette la stessa Wellnitz, i protocolli riguardanti i livelli più bassi delle gerarchie militari italiane prima del 1943 sono assai scarsi e quindi non è dato sapere in che modo si sia sviluppata la crisi della coesione dell’esercito italiano. Una comparazione adeguata tra il caso italiano e quello tedesco rimane perciò, nonostante i due saggi siano un buon inizio, affidata a ricerche future.
“Der Führer war wieder viel zu human, viel zu gefühlsvoll”. Der Zweite Weltkrieg aus der Sicht deutscher und italienischer Soldaten, [„Il Führer è stato ancora una volta troppo umano , troppo sentimentale“. La seconda guerra mondiale dal punto di vista dei soldati tedeschi e italiani], a cura di H. Welzer, S. Neitzel, C. Gudehus. Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 2011, 464 pp.
Paolo Fonzi
[1] E. A. Shils, M. Janowitz, Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht in World War II, Public Opinion Quarterly, 1948, 12, 2, pp. 280-315.
[2] Discutono direttamente questa tesi O. Bartov, Hitler’s Army. Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich, New York, Oxford University Press, cap. 2; T. Kühne, Kameradschaft: die Soldaten des nationalsozialistischen Krieges und das 20. Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. Gli studi sull’esperienza di guerra in Germania sono molto numerosi e di notevole raffinatezza teorica, cfr. ad es . il volume collettaneo frutto delle ricerche di un gruppo di studiosi dell’Università di Tubinga, N. Buschmann, H. Carl (a cura di), Die Erfahrung des Krieges: erfahrungsgeschichtliche Perspektiven von der französischen Revolution bis zum zweiten Weltkrieg, Paderborn, Schöningh, 2001.
[3] Interessanti le considerazioni di K.A. Kilian, Das Medium Feldpost als Gegenstand interdisziplinärer Forschung: Archivlage, Forschungsstand und Aufbereitung der Quelle aus dem Zweiten Weltkrieg, Diss. Berlin, Techn. Univ. 2001. Basato interamente su questa fonte è lo studio di K. Latzel, Deutsche Soldaten – nationalsozialistischer Krieg? Kriegserlebnis – Kriegserfahrung 1939-1945, Paderborn, Schöningh, 1998. L’autore ha sviluppato interessanti considerazioni metolodogiche sulla posta militare e l’esperienza di guerra in K. Latzel, Vom Kriegserlebnis zu Kriegserfahrung. Theoretische und methodische Überlegungen zur erfahrungsgeschichtlichen Untersuchung von Feldpostbriefen, Militärgeschichtliche Mitteilungen, 1997, 56, 1, pp. 1-30.
[4] S. Neitzel, Abgehört: Deutsche Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft 1942-1945, Berlin : Propyläen, 2005.
[5] Welzer è considerato un esperto di Täterforschung, la ricerca sui perpetratori, su cui cfr. H. Welzer, Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2005.
[6] H. Weltzer, S. Neitzel, Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2011.
[7] A. Lüdtke, Einleitung. Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte?, in A. Lüdtke (a cura di), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Campus, Frankfurt am Main/New York, 1989, pp. 9-47.
[8] F. Römer, Der Kommissarbefehl: Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42, Paderborn, Schöningh, 2008.
[9] A. Lüdtke, War as Work. Aspects of Soldiering in Twentieth-Century Wars, in A. Lüdtke, B. Weisbrod (a cura di), No man’s land of violence: extreme wars in the 20. Century, Göttingen, Wallstein Verlag, 2006, pp. 129-151.
[10] Qui Römer utilizza la teoria di G. L. Siebold, The Essence of Military Group Cohesion, in Armed Forces and Society 2007, 33, pp. 286-295, secondo cui la coesione è garantita solo dal concorrere di quattro tipi di legame: peer (horizontal), leader (vertical), organizational e institutional bonding.
[11] Cfr. M. Christ, Die Dynamik des Tötens. Die Ermordung der Juden von Berditschew, Ukraine 1941-1944, Frankfurt am Main, Fischer-Taschenbuch-Verl., 2011. Qui l’autrice sulla base di fonti di diversa natura analizza lo sviluppo della violenza degli occupanti nazisti nella città ucraina di Berdyčiv.
[12] Sulla base delle stesse fonti l’autore ha scritto anche un libro in italiano: A. Osti Guerrazzi, Noi non sappiamo odiare. L‘esercito italiano tra fascismo e democrazia, Torino, Utet, 2010.